Il cuore messo a nudo. Scrittura e identità in Mitologia d’infanzia di Laura Bocci
“Je peux commencer Mon coeur mis à nu n’importe où, n’importe comment, et le continuer au jour le jour, suivant l’inspiration du jour et de la circonstance, pourvu que l’inspiration soit vive”: così l’inizio di quel ritratto intimo e diaristico baudelairiano che trova la propria ragione d’essere nella narrazione di un cuore esposto, messo a nudo, come o dove non ha importanza, ciò che conta è che sia riflessione di un’urgenza che parte dal sé. Un progetto che pone al centro l’io e che anticipa di gran lunga le riflessioni sull’autobiografia che attraverseranno il Novecento. Penso, ad esempio, ai Diari di Franz Kafka, dove il frammento, l’epifania verbale, si rivelano nella miriade di appunti, riflessioni, annotazioni, che si mescolano a progetti di racconti e lavori da scrivere. Scrittura nella scrittura e intanto l’autobiografia, come l'avrebbe intensa Philippe Lejeune, si sfalda sotto ai colpi della sua stessa materia; ma penso anche a L’analfabeta di Ágota Kristóf, in cui la materia autobiografica si intreccia alla lingua straniera, all’esilio, alla perdita dell’infanzia e della patria, in cui l’io si racconta per sottrazione, come se la verità del sé potesse emergere solo nel vuoto lasciato dalle parole non dette. E proseguendo in questa direzione non posso fare a meno di ritornare con la memoria a Pierre Bourdieu, Questa non è un’autobiografia: avvertimento e titolo al tempo stesso della sua opera postuma, che decostruisce l’illusione di un sé trasparente e lineare, sostituendolo con una narrazione stratificata, attraversata dalle strutture sociali e dalle contingenze storiche. “Io non esisto. Io coesisto”: le parole di Serge Doubrovsky risuonano e illuminano l’identità trasformandola in luogo in cui si coagulano e si disfano continuamente le immagini del sé, in bilico tra verità e finzione, tra memoria e desiderio.
È in questa zona liminale, tra identità e perdita, tra racconto e interrogazione, che si inserisce Mitologia d’infanzia di Laura Bocci (Vallecchi, 2021) e che si situa con consapevolezza al crocevia tra vita e letteratura. Fin dalle prime pagine è esplicitato l’intento della scrittrice: Bocci non tenta solo di rievocare la propria infanzia, ma cerca di sigillarla nel linguaggio, di restituirle forma attraverso una narrazione che diventa costruzione, stratificazione. La possibilità di raccontare l’io attraverso la scrittura pone, da subito, delle domande alle quali, con la tenacia e la costanza di un’archeologa della letteratura, Bocci proverà a rispondere:
“La prima cosa da chiedersi è se la bambina sia mai veramente esistita, e se si possa affermare che abbia avuto una sua piccola storia da zero a nove anni, sullo sfondo degli eventi che erano accaduti ad altre persone nel passato, quando lei ancora non c’era (non-essere-ancora era una cosa davvero inimmaginabile) e che durante la sua infanzia via via accadevano agli adulti che la circondavano. Lei bambina e l’adulta che poi è diventata si sono lasciate tanto tempo fa e mai più incontrate, se non ora qui, in queste pagine. C'è una continuità, tra loro? L'essenza della donna che oggi è esisteva già nella bambina di allora? Cosa è rimasto, di lei, grazie alla sua forza e alla sua inconscia ma tenace resistenza? La vita ha il suo percorso, uguale per tutti, nascita sviluppo e morte, lei invece è rimasta fissata nell'immutabile limbo senza tempo dell'infanzia, mitologico ed eroico”.
In questo racconto, la storia personale della bambina di ieri si fonde con i ricordi della donna di oggi. Ed è proprio in questa sovrapposizione di voci e tempi che si struttura il nucleo profondo dell’opera: un’indagine sull’infanzia che affonda le radici nell’Italia degli anni Cinquanta, ma che poi risale ancora più indietro, nei racconti delle nonne, nella memoria orale del parentado, in una genealogia femminile che diventa insieme origine e orizzonte. È proprio questa genealogia femminile a svolgere un ruolo chiave nella narrazione. Sono le donne, con le loro storia private, i loro “momenti di essere”, a orientare il percorso della protagonista e, con lei, quello di chi legge. Alcune tentano, chi con più coraggio, chi con esitazione o rinuncia, di far sentire la propria voce; altre restano confinate in un destino che non hanno scelto. Ma tutte, in un modo o nell’altro, aprono uno spazio di riflessione sulla condizione femminile, molti anni prima che il femminismo la tematizzasse apertamente. Ed è in questo spazio, carsico ma potentissimo, che la scrittura di Bocci si innesta, facendo emergere dal fondo della memoria individuale una coralità sommersa, capace ancora oggi di interrogarci.
Mitologia d’infanzia si muove lungo la sottile linea che separa e insieme unisce l’intimo e l’altro, la memoria individuale e le forme storiche del vivere collettivo. L’intreccio di scrittura e fotografia, di reperti cartacei e immagini d’epoca, è un dispositivo di scavo, un metodo di ricostruzione che avvicina l’opera al pensiero di Pierre Bourdieu, per il quale “la storia dell’individuo non è altro che una certa specificazione della storia collettiva del suo gruppo o della sua classe”.
Mitologia d’infanzia non rinuncia all’“io”, ma lo immerge in un contesto, in un tessuto sociale e in una genealogia familiare e culturale. In questa prospettiva, la scrittura autobiografica si fa auto-socio-biografia, secondo la definizione di Annie Ernaux, e il racconto personale fa emergere la singolarità come parte viva della storia di tutti.
Ed ecco che risuona nuovamente il canto di Baudelaire, quel cuore messo a nudo, quel cuore pulsate che in Mitologia d’infanzia si fa nucleo di partenza e d’arrivo di una storia più grande che dall’“io” sconfina nel “noi”, una storia in cui, citando Georges Perec, “il tempo ritrovato si confonde con il tempo perduto” e il libro diventa “la misura del tempo della scrittura” che gioca con il tempo dell’infanzia, “mitologico ed eroico”.









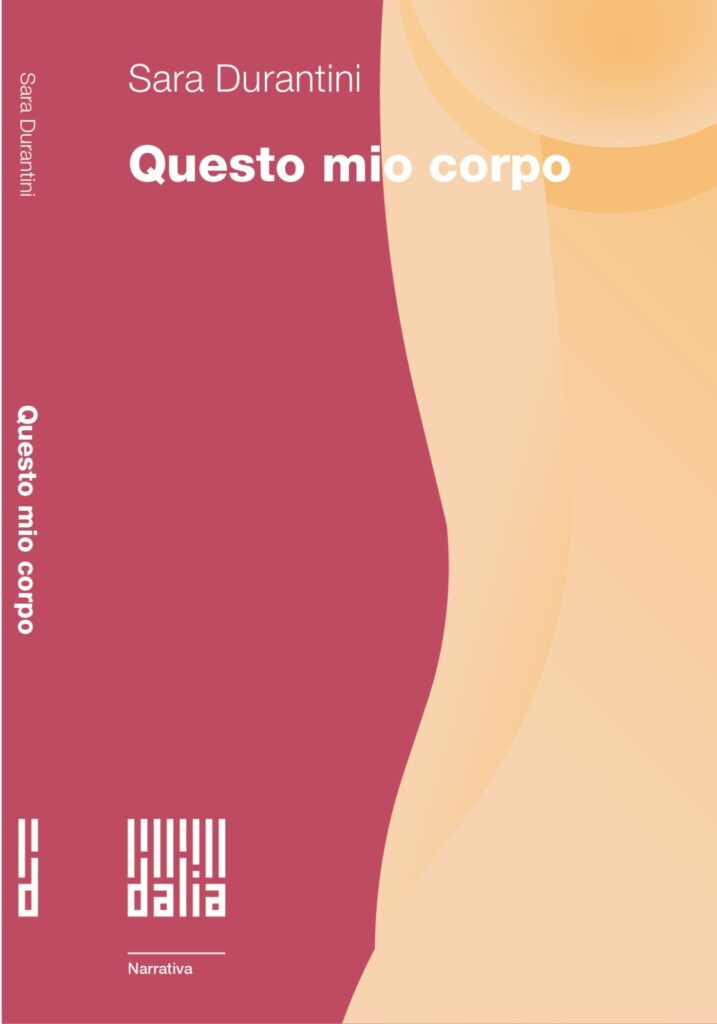



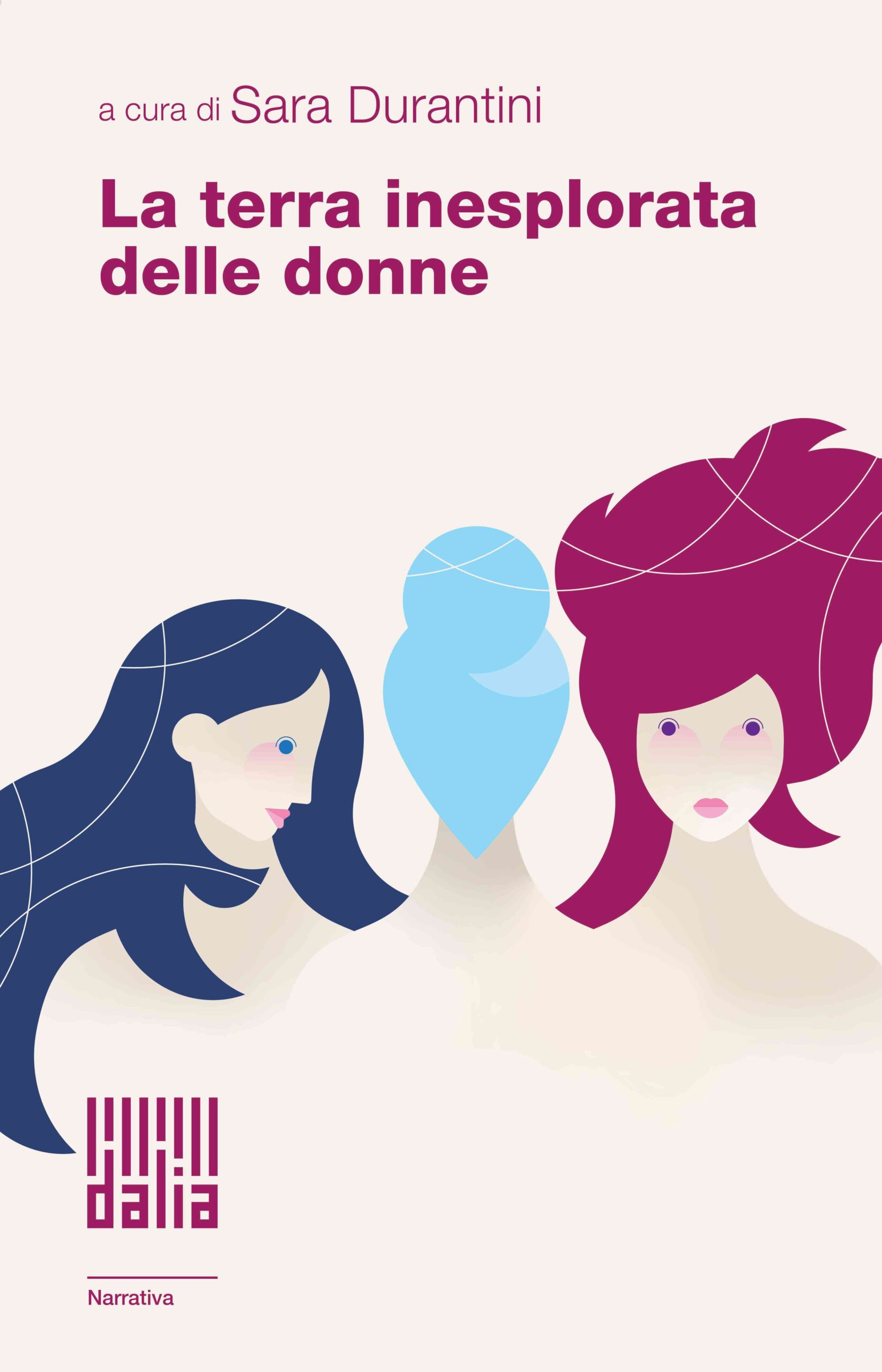


Nessun commento: